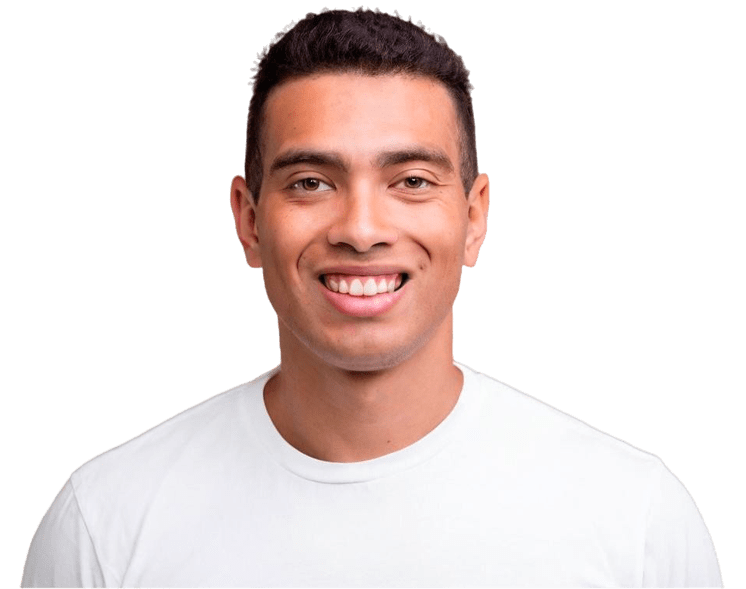Età avanzata, stile di vita poco equilibrato, fattori ambientali: lo sviluppo delle malattie oculari è influenzato da moltissime variabili che spesso sono difficili da definire, ma un ruolo di grande importanza è ricoperto dall’ereditarietà. La trasmissione genetica ha un forte impatto sullo stato di salute degli occhi, e può esporre un individuo alla probabilità di sviluppare difetti visivi e patologie.
Ma quanto è forte l’impatto dei geni sulla vista? Scopriamolo insieme!
Perché alcuni difetti visivi sono ereditari?
Le numerose ricerche oftalmiche (nello specifico nel campo della genetica della vista) hanno evidenziato la correlazione tra vista e DNA, individuando un numero notevole di problemi di vista genetici, ossia influenzati da fattori ereditari.
Per ereditarietà si intende la trasmissione di alcuni geni dai genitori ai figli (o da una generazione all’altra), determinando così le caratteristiche dell’individuo e talvolta anche la sua predisposizione a malattie specifiche. Tra queste si possono individuare varie mutazioni genetiche che influenzano la vista, causando dai più comuni difetti refrattivi (miopia, astigmatismo e ipermetropia) alle patologie visive più serie e rare (maculopatie, retinopatie, glaucoma, cataratta, etc.).
L’ereditarietà dei difetti visivi non è tuttavia l’unico fattore in gioco, poiché ogni singola problematica può essere causata o esacerbata da vari fattori, come uno stile di vita poco equilibrato, condizioni ambientali, abitudini lavorative e la presenza di patologie correlate.
I principali difetti visivi ereditari
L’ereditarietà nei difetti refrattivi si può registrare soprattutto nelle problematiche visive che si sviluppano in giovane età. Per questo motivo in alcuni casi la miopia può essere ereditaria, così come ipermetropia e astigmatismo. La presbiopia invece è un disturbo fisiologico, che si manifesta a causa del naturale invecchiamento dell’occhio.
Tutto questo non si riscontra però solamente nel caso dei disturbi di rifrazione, ma anche con patologie più particolari, che possono svilupparsi casualmente o essere trasmesse da uno o entrambi i genitori. Approfondire la questione è utile per avere una conoscenza più precisa di come queste malattie possono manifestarsi e aiuta i medici a indagare preventivamente il problema, in modo da prevenirlo, rallentarne lo sviluppo o ideare trattamenti efficaci.
Miopia: quanto conta l’ereditarietà?
La miopia è uno dei difetti refrattivi più comuni, causato da una lunghezza eccessiva del bulbo oculare, per cui l’occhio fatica a mettere a fuoco le immagini lontane. I fattori che favoriscono lo sviluppo di questa problematica sono molteplici e spesso sono influenzati da abitudini e stile di vita.
Ricerche scientifiche – riportate sulla rivista Nature Genetics – hanno tuttavia evidenziato che i soggetti portatori di alcuni geni sono più propensi a sviluppare una miopia ereditaria, con un rischio dieci volte superiore rispetto ad altri soggetti. Tali geni sono responsabili per esempio degli impulsi nervosi che inviano i segnali visivi, del metabolismo dell’acido retinoico, della struttura dell’occhio e dei tessuti oculari, e della presenza di eventuali malformazioni.
Malgrado il legame tra questi problemi della vista e la genetica sia forte, esistono anche delle condizioni che possono aggravare la miopia, e che rendono l’ereditarietà della vista solo un fattore tra tanti che concorre allo sviluppo del difetto:
- Attività svolta in condizioni di scarsa illuminazione
- Uso prolungato di schermi digitali
- Eccessiva visione da vicino
- Uso scorretto di occhiali e lenti a contatto
- Dieta povera di vitamine utili per la salute oculare
Astigmatismo e fattori genetici
Tra i problemi di vista genetici più comuni si trova anche l’astigmatismo. Questo difetto visivo si presenta quando la cornea del paziente presenta una forma irregolare, una curvatura più ovoidale che sferica. Questa particolare conformazione causa la scorretta ricezione degli impulsi visivi e una visione offuscata delle immagini vicine.
Rispetto ad altri difetti della vista come la miopia, l’ereditarietà dell’astigmatismo in questo caso gioca un ruolo centrale nello sviluppo del problema, in quanto fattore che più influenza il suo sviluppo. Un individuo che presenta genitori o altri parenti affetti da questa problematica, ha buone probabilità di soffrirne anche lui.
Esistono però dei fattori secondari, come traumi all’occhio o la presenza di cheratocono, una patologia che deforma la cornea fino a farle assumere una particolare conformazione a cono.
Ipermetropia: predisposizione genetica o ambientale?
Come per l’astigmatismo, anche l’ipermetropia è uno dei più frequenti difetti visivi congeniti, che provoca nel paziente una visione sfocata da vicino. In molti casi, infatti, sono i geni a determinare la curvatura della cornea e la forma del bulbo oculare, che nei pazienti affetti da questo tipo di anomalie della vista appare più corto rispetto agli individui sani.
In genere la maggior parte dei bambini risulta affetta da ipermetropia alla nascita, ma con la crescita il difetto si attenua e in molti casi resta silente fino all’età adulta. In caso di ipermetropia ereditaria o sporadica il cristallino compensa la capacità di messa a fuoco, ma è anche frequente percepire disturbi come affaticamento oculare e mal di testa.
Cheratocono: un’anomalia genetica della cornea
L’ereditarietà non è un fattore rilevante solo per quanto riguarda i difetti di rifrazione, ma gioca un ruolo di spicco anche nello sviluppo di molte malattie oculari genetiche. Conoscere la storia familiare di un paziente e la sua predisposizione alle malattie ereditarie di questo tipo è fondamentale per sottoporlo a screening regolari ancora più approfonditi, e fare il possibile per prevenire o monitorare l’insorgere della malattia.
Il cheratocono è una di queste: si tratta di un’anomalia della vista di tipo degenerativo che colpisce la cornea, causandone l’assottigliamento e l’alterazione, fino a farle assumere una forma allungata verso l’esterno simile a quella di un cono.
Tra le conseguenze di questa patologia – che insorge in genere in età adolescenziale e tende a rallentare in età adulta – spiccano un abbassamento generale della capacità visiva, il peggioramento dell’astigmatismo o della miopia e – nei casi più gravi – la possibilità di perdere del tutto la vista, in assenza di un trattamento adeguato.
Rispetto a molte altre malattie oculari, l’ereditarietà del cheratocono è meno frequente, poiché è stata riscontrata solo nel 14% dei casi. La gran parte dei pazienti che ne sono affetti sviluppano in realtà il problema senza una causa primaria, sebbene esso possa essere peggiorato o favorito da un frequente o eccessivo sfregamento degli occhi, danni, esposizione prolungata ai raggi UV e altre retinopatie.
Glaucoma e rischio ereditario
La trasmissione ereditaria è invece molto più significativa nello sviluppo del glaucoma, una dei problemi di vista genetici più preoccupanti per quanto riguarda la degenerazione della capacità visiva, causato da un’elevata pressione intraoculare che danneggia il nervo ottico.
Poiché le patologie oculari come il glaucoma possono rimanere silenti per anni e non c’è modo di individuarle senza degli esami approfonditi, è fondamentale sottoporsi regolarmente alle visite di routine, soprattutto se nella propria genealogia ci sono familiari che hanno sofferto di questa patologia. Malgrado i geni che regolano l’insorgere del glaucoma siano ancora in fase di studio, comunicare all’oculista la possibile ereditarietà del glaucoma è molto importante per adottare delle misure preventive o per diagnosticarlo in tempi rapidi.
Cataratta congenita: quando i geni sono determinanti
La comune cataratta è causata da un naturale invecchiamento del cristallino, che – soprattutto sopra i 70 anni – si opacizza e causa un annebbiamento della vista e la sua perdita progressiva.
Esiste però un tipo di cataratta ereditaria, ossia indipendente dall’età e dall’invecchiamento dell’occhio: la cataratta congenita. Questa patologia rientra della categoria dei difetti visivi congeniti e colpisce il bambino nei primi mesi di vita o addirittura in fase di gestazione, compromettendo la sua capacità visiva. L’ereditarietà è presente circa nel 30% dei casi, con una trasmissione diretta da parte dei genitori.
La causa genetica non è tuttavia l’unica, poiché questa problematica può essere influenzata da altri fattori, come malattie del feto, infezioni in gravidanza, nascite premature, problemi metabolici della madre, assunzione di farmaci o uno stile di vita poco equilibrato durante la gestazione.
Malgrado alla nascita il neonato venga sottoposto a numerosi esami che permettono di individuare subito la presenza del problema, tenere conto dei fattori genetici è molto importante per il trattamento di queste malattie oculari ereditarie, poiché aumenta la possibilità di prevenire o curare il problema tempestivamente e senza serie conseguenze.
Il ruolo della genetica nella salute visiva
Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, la salute visiva può essere compromessa da numerosi fattori, non ultimi quelli genetici, che giocano un ruolo importante nello sviluppo della capacità visiva dei pazienti. Studiare la trasmissione dei geni interessati da patologie e la loro eventuale mutazione è molto importante per prevenire alcuni problemi di vista o per tenere sotto controllo le malattie più rare e gravi.
Geni e mutazioni: come influenzano la vista
Ogni caratteristica di un essere umano è scritta nel suo codice genetico, e non solo i tratti fisici che lo distinguono dagli altri individui (come colore degli occhi e dei capelli, forma del naso, e così via), ma anche il funzionamento stesso delle cellule. Poiché esiste un legame tra vista e DNA, le alterazioni che si manifestano all’interno dei geni possono causare anomalie oculari.
Molte malattie particolari – maculopatie, patologie retiniche, glaucomi e così via – sono causate proprio da queste mutazioni genetiche della vista, che possono manifestarsi casualmente durante lo sviluppo embrionale e senza fattori genetici, oppure essere ereditarie. In quest’ultimo caso l’alterazione avviene nel DNA dei genitori e si trasmette alla prole, causando un malfunzionamento delle cellule oculari. In altri casi il gene della vista alterato rimane latente senza dare alcun problema.
Malattie oculari genetiche rare
Le ricerche condotte nel campo dell’oculistica genetica sono molto importanti, poiché permettono di effettuare diagnosi precoci e stabilire un piano di prevenzione, contenimento o controllo delle malattie oculari genetiche.
Alcune tra le patologie oculari più note:
- Retinite pigmentosa ereditaria: questa malattia provoca cecità notturna, alterazioni retiniche e riduzione del campo visivo, fino a una progressiva perdita della vista. Le cause del suo sviluppo vanno individuate nella mutazione di alcuni geni che regolano il funzionamento delle cellule retiniche, che svolgono la funzione di fotoricettori. Questo può avvenire in modo sporadico, oppure attraverso la trasmissione da parte dei genitori.
- Distrofia corneale: comprende varie malattie ereditarie piuttosto rare che colpiscono il tessuto della cornea, facendole perdere trasparenza. I sintomi possono essere silenti in alcuni casi, oppure provocare fastidi, sensibilità alla luce, dolore e perdita di capacità visiva. Queste patologie sono solitamente causate dalla mutazione di vari geni, alcuni dei quali non sono ancora stati identificati.
- Malattia di Stargardt: si tratta di una maculopatia ereditaria che colpisce la retina e che in genere viene trasmessa da entrambi i genitori, sebbene in alcuni casi molto rari può essere presente in un solo soggetto. La causa va attribuita alla mutazione del gene ABCA4, che causa un accumulo di sostanze di scarto all’interno della retina, e una conseguente perdita progressiva della capacità visiva centrale.
- Sindrome di Leber: questa neuropatia ottica degenerativa attacca il nervo ottico e si manifesta in giovane età e causa una progressiva perdita della visione bilaterale. Responsabile di questa anomalia della vista è la mutazione di vari geni, che vengono trasmessi sempre dalla madre.
Occhio pigro e fattori genetici
Meno grave rispetto ai difetti visivi congeniti precedentemente trattati, l’ambliopia (comunemente detta sindrome dell’occhio pigro) è una condizione che può compromettere la capacità visiva di chi ne soffre, con un impatto serio sulla qualità della vita.
Questa problematica si verifica principalmente durante l’infanzia e si manifesta quando uno dei due occhi presenta un potere visivo poco sviluppato. L’attività visiva viene dunque affidata principalmente all’occhio sano, causando affaticamento, perdita della capacità visiva, fatica nel percepire la profondità visiva e offuscamento.
L’ereditarietà dell’occhio pigro è una delle cause della patologia, assieme ad altre problematiche come cataratta congenita, strabismo e la mancata correzione di un difetto refrattivo.
Fattori ambientali vs ereditarietà
Ogni volta che si parla di ereditarietà dei difetti visivi, è fondamentale ricordare che i fattori genetici non sono l’unica causa. Un ruolo centrale è svolto anche dalle abitudini dell’individuo, dal suo stile di vita e da fattori ambientali.
Il ruolo dell’alimentazione, dello stile di vita e della protezione solare
Sebbene ci siano numerosi fattori che regolano la salute degli occhi e lo sviluppo di eventuali difetti della vista, mantenere uno stile di vita sano è cruciale per migliorare il proprio benessere visivo. Le buone pratiche da adottare tutti i giorni sono svariate, ma tra queste spiccano 3 elementi chiave, utili anche per i soggetti predisposti geneticamente a varie patologie visive:
- Alimentazione e stile di vita sano: la nostra alimentazione ha un impatto significativo su moltissimi processi corporei, e la vista non sfugge a questa regola. Per questo è fondamentale adottare una dieta bilanciata, che a zuccheri e grassi favorisca l’assunzione di sostanze benefiche per la vista, come le vitamine C, A ed E, gli omega-3, gli omega-6 e gli antiossidanti. Allo stesso modo è importante ridurre il consumo di bevande alcoliche ed evitare quanto possibile il fumo, poiché quest’ultimo può favorire il progredire di alcune patologie come cataratta e degenerazione maculare.
- Attività fisica: seguire uno stile di vita sano significa anche svolgere una regolare attività fisica, che ha un impatto sul benessere generale del corpo, ma anche sulla salute degli occhi. Fare lunghe camminate, fare jogging o nuotare tiene sotto controllo sia la pressione arteriosa che quella che interessa agli occhi.
- Protezione e controlli regolari: l’occhio è esposto a molti stimoli, dalle fonti luminose agli agenti esterni. Per mantenerlo sano è fondamentale proteggerlo da vento, polvere e raggi UV, evitando il più possibile la polvere e altre sostanze che potrebbero provocare danni, e utilizzando regolarmente degli occhiali da sole. La luce UV, contenente radiazioni, può infatti causare problemi di vista come infiammazioni, nonché accelerare la cataratta e la degenerazione maculare.
Altrettanto importante è sottoporsi a controlli medici e oculistici regolari, a maggior ragione se si è riscontrato un legame tra la propria eredità genetica e la salute visiva e si soffre di patologie correlate ai disturbi visivi, come ipertensione e diabete, o vere e proprie patologie oculari.
Digitalizzazione e affaticamento visivo: esiste un legame genetico?
Il legame tra vista e genetica è ormai comprovato, ma questo influisce anche sull’affaticamento visivo causato dall’uso di schermi digitali?
Non proprio, o meglio, la trasmissione di determinati geni non rende un soggetto più o meno sensibile agli schermi, ma può provocare problemi di vista genetici e patologie che possono peggiorare a causa l’utilizzo prolungato di display, nonché affaticare molto l’occhio. Tra queste ci sono la miopia, la secchezza oculare, la fotofobia e molte malattie retiniche.
Con la massiccia digitalizzazione che sta interessando gli ultimi anni e una modalità di lavoro sempre più legata all’utilizzo di dispositivi digitali, è molto difficile ridurre l’esposizione dell’occhio ai display, ma esistono delle piccole accortezze che possono migliorare il benessere visivo:
- Posizionare lo schermo a circa 50-70 cm dagli occhi.
- Scegliere una disposizione all’interno della stanza che non crei riflessi sullo schermo.
- Utilizzare il display in una stanza ben illuminata.
- Utilizzare degli occhiali con filtro per la luce blu o regolare la luminosità del computer tramite le impostazioni.
- Sbattere spesso le palpebre o usare colliri per idratare gli occhi.
- Effettuare pause regolari, con 20 secondi di pausa ogni 20 minuti, fissando un punto in lontananza per allenare la muscolatura degli occhi e dare loro riposo.
Diagnosi e prevenzione
Approfondire l’ereditarietà di un problema visivo non serve solo a conoscere la propria storia clinica e quella della propria famiglia, ma è importante per effettuare una diagnosi precoce e aumentare le possibilità di trattare il problema prima che si sviluppi in modo serio.
Quando fare un controllo genetico?
Per quanto affrontare il tema della genetica della vista sia utile per individuare potenziali malattie ereditarie, in alcuni casi non ci sono elementi concreti che rendono necessario effettuare test mirati. Un controllo presso il proprio oculista, con esami mirati e approfonditi è invece consigliato quando il paziente è al corrente di malattie oculari ereditarie nella propria famiglia, come glaucoma o retinopatie.
È inoltre buona norma sottoporsi a test genetici quando ci si trova in fase gestazionale, per determinare la presenza di fattori genetici che potrebbero trasmettersi al bambino.
Approfondire il problema attraverso test di oculistica genetica, è infine consigliato anche in caso di problematiche visive che si manifestano in età infantile (come la cataratta congenita o l’ambliopia) o quando la vista subisce un peggioramento progressivo che non sia spiegabile con dei difetti refrattivi.
Esami oculistici per individuare difetti ereditari
Una volta stabilita la presenza di difetti visivi congeniti in famiglia, è importante affiancare alle normali visite oculistiche di routine dei test genetici specifici, che permettono di individuare eventuali mutazioni genetiche che predispongono un individuo a patologie oculari specifiche.
Il test genetico consiste nel prelievo di un piccolo campione di DNA (attraverso delle analisi del sangue o nella raccolta di un po’ di saliva), che verrà poi analizzato in laboratorio attraverso il cosiddetto sequenziamento del DNA.
In modo automatico verrà identificata la presenza o meno della mutazione, interpretatada un team di oftalmologi esperti.
Conclusioni
Le malattie della vista e i difetti refrattivi possono essere favoriti o esacerbati da condizioni ambientali, uno stile di vita sregolato e da abitudini poco sane, ma i fattori genetici svolgono un ruolo centrale nello sviluppo di queste problematiche, andando a causare anche patologie serie che colpiscono l’occhio.Individuare la storia clinica della famiglia ed eventuali alterazioni genetiche è fondamentale per effettuare una diagnosi precoce, per prevedere come la malattia potrebbe svilupparsi, identificare una possibile terapia o valutare il rischio di future trasmissioni.